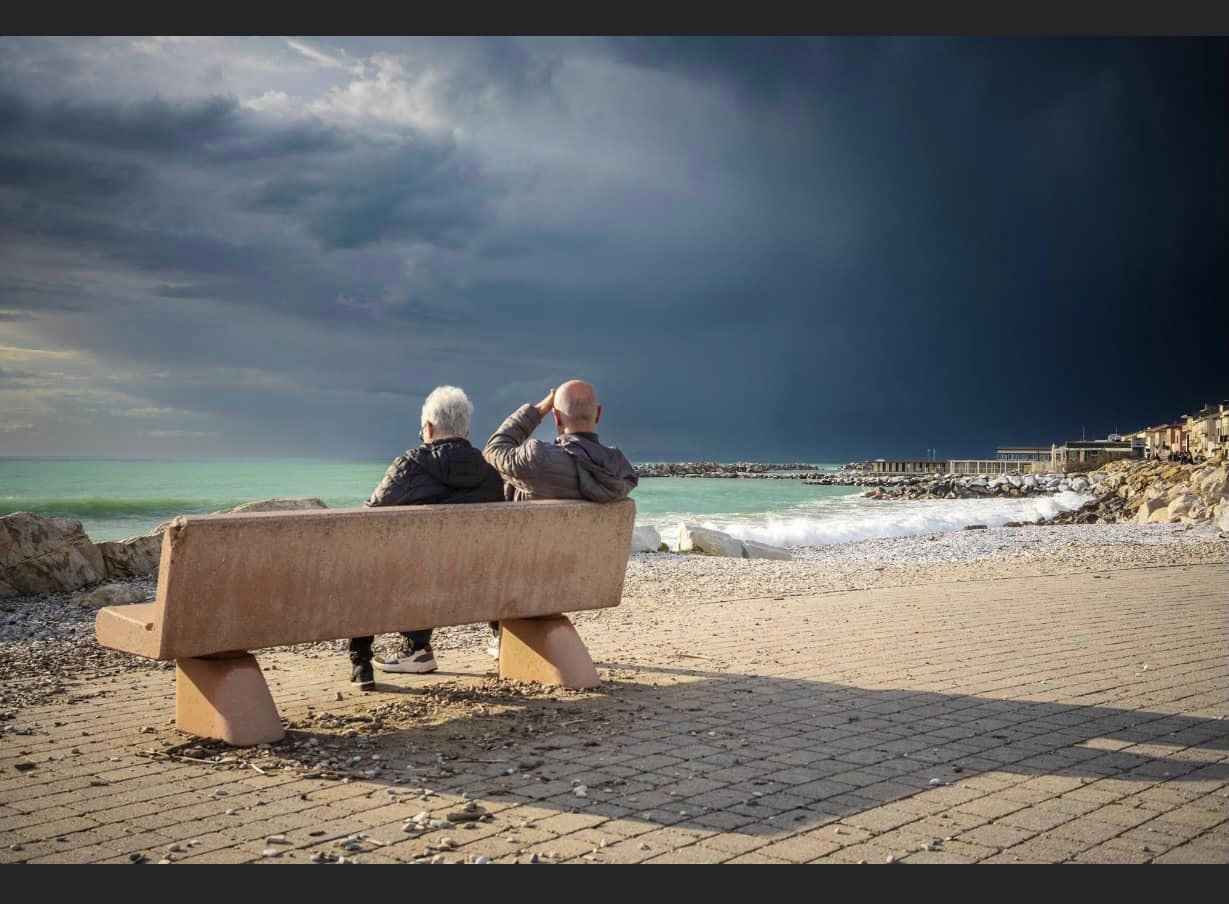Ha passato una vita in carcere, ma non come detenuto. Francesco Ceraudo dietro le sbarre ha lavorato come Medico penitenziario, dirigendo per diversi anni il Centro Clinico del carcere Don Bosco di Pisa. Nel suo libro “Uomini come bestie” (Edizioni Ets), fa un lungo e dettagliato racconto di un mondo che molti preferiscono non vedere. Eppure le carceri aiutano a capire tante cose. Voltaire diceva: “Non fatemi vedere i vostri palazzi, ma le vostre carceri, poiché è da esse che si misura il grado di civiltà di una nazione”. Ceraudo ci conduce per mano a vedere cosa accadeva (e accade) nelle nostre prigioni. Che, ricordiamolo, come dice la Costituzione devono essere un luogo di pena ma anche di rieducazione.
Professore, il suo libro traccia una spaccato interessante sul nostro sistema carcerario. Quale insegnamento ha tratto dalla sua lunga esperienza lavorativa?
È stato un percorso lungo e faticoso. Dagli anni bui del terrorismo fino alle carceri superaffollate. Un percorso di coraggiosa cronaca che mette a nudo e denuncia le aberrazioni e la disumanità del sistema carcerario italiano. Un carcere brutto, inutile, cattivo e vendicativo. Un carcere che calpesta principi fondamentali della nostra carta costituzionale. I risultati acquisiti non sono proporzionali all’impegno profuso. Un carcere malato.
E la sua più grande soddisfazione?
Quella di essere riuscito ad acquisire la fiducia dei detenuti. Molte volte, però, mi sono identificato con un cane che abbaia alla luna.
Brusca, Liggio, Madonia, Santapaola, Michele Greco, Di Maggio, Vallanzasca, Moretti, Curcio, Turatello e molti altri. L’elenco di “detenuti vip” di cui parla nel suo libro è impressionante…
La mafia ha le sue regole spietate, per noi inaccettabili, ma per chi vive in quel contesto, dogmi da non discutere. Si rileva un comportamento ligio al regolamento penitenziario e la fede ostentata verso Santa Rosalia e Padre Pio. Una maschera d’indifferenza e nervi d’acciaio, dietro la quale però soffrono maledettamente. Vivono tanto intensamente dentro di loro certe emozioni che, alla fine, risultano quasi tutti malati di cuore.
Nel suo libro affronta anche la strage di Bologna, con una tesi che smentisce la verità processuale…
La strage di Bologna è stata indicata come uno degli ultimi atti di quella che è definita la strategia della tensione. Alcuni avvenimenti accaduti sotto la mia personale attenzione mi portano ad affermare che Francesca Mambro e Valerio Fioravanti non sono gli autori della strage.
Perché afferma questo?
Sulla base dell’interpretazione dei fatti, non delle ideologie precostituite. Tutto deve essere ricondotto alla figura di Massimo Sparti, che è riuscito ad acquisire una certificazione di malattia a prognosi severamente infausta totalmente falsa e in base alla quale ottenne la libertà. La contropartita era accusare Mambro e Fioravanti quali autori della strage di Bologna.
Lei racconta che nel suo ufficio dislocato al Centro Clinico Penitenziario di Pisa aveva una bacheca dove metteva tutti gli oggetti più strani che riusciva a recuperare dallo stomaco dei suoi pazienti… un elenco sorprendente e impressionante. Ricorda gli oggetti più strani ingeriti dai detenuti?
Oggetti non solo ricavati dallo stomaco direttamente, ma anche quelli eliminati per vie naturali. Un vasto campionario: tagliaunghie, forchette, cucchiai, coltelli, lamette, pile, pezzi di vetro e di ceramica, catenine, molle del letto, aghi da cucito ecc.ecc.
Il suo libro ha una prefazione scritta da Adriano Sofri, un altro detenuto vip che ha incontrato. Che ricordo ha di lui?
Per circa dieci anni Adriano Sofri è stato detenuto alla cella n°1 della Sezione Penale del carcere Don Bosco di Pisa. Non ha mai voluto chiedere la grazia. Erano in gioco il suo orgoglio, la sua dignità. Non ha mai abbassato la testa. Gli sono stato vicino, parlandogli, ascoltandolo attentamente. Ho intravisto in lui un uomo che sopporta una condanna a suo dire ingiusta con straordinaria forza d’animo. Preservo il ricordo di un grande benefattore nei confronti dei suoi compagni di sventura. Anche per questo continuo a volergli bene.
Aragoste e gamberoni, champagne, sesso a pagamento. Nel suo libro si parla dello scandalo al carcere Don Bosco di Pisa, che sembrava un luccicante bazar. Ricordiamo poi che ci furono pesanti condanne per il direttore e per il comandante della Polizia Penitenziaria. Il clima che si respirava non doveva essere facile. Come fece a resistere?
Il pm Giambartolomei concluse la sua arringa precisando che i detenuti del carcere Don Bosco di Pisa erano costretti a pagare pure l’aria che respiravano. Sono avvenuti fatti gravissimi che si scontravano con l’umana coscienza, commessi su una fetta di umanità umiliata e indifesa. È stato toccato il fondo del precipizio, un precipizio intriso di minacce, intimidazioni, aggressioni fisiche, pestaggi, accoltellamenti, omicidi. Al solo ricordo avverto i brividi, ma debbo riconoscere che questo scandalo è stata una sorta di vaccinazione che mi ha fatto tenere sempre gli occhi aperti nei confronti di tutti gli avvenimenti successivi.
Bambini dietro le sbarre: un altro problema molto diffuso. Si può fare qualche cosa per migliorare la situazione?
Un bambino in carcere è un fatto intollerabile in quanto il carcere è un’istituzione punitiva. Non si può non aderire allo sdegno che suscita questa denuncia, per la carica di violenza contenuta nel fatto in sé. Come si delineano il suo orizzonte, il suo linguaggio, la sua capacità di movimento negli spazi ristretti della cella? Per migliorare le cose basterebbe applicare integralmente la cosiddetta Legge Finocchiaro, che tutela il rapporto genitori-figli dando vita a due nuove istituzioni: la detenzione domiciliare speciale e l’assistenza all’esterno di figli minori.
Nell’ultima parte del libro si sofferma sul caso Cucchi. Che idea si è fatto?
Il caso Cucchi è sconcertante. I vari gradi del processo si sono prestati alle ambigue risultanze di alcune perizie e consulenze che sono riuscite a capovolgere la realtà senza nemmeno porsi il problema di rendere credibile quello che veniva scritto. Le lesioni traumatiche e soprattutto le modalità hanno creato le premesse per l’instaurarsi di un quadro psicopatologico che ha dominato il campo, sconfinando nella sindrome da inanizione (astensione da alimenti e liquidi).
Si delinea così un’evidente catena causale che collega l’aggressione, il trauma psichico e la sindrome da inanizione. Sui medici della Struttura Protetta dell’Ospedale Pertini ricade la grave responsabilità di non aver redatto la certificazione di assoluta incompatibilità con il regime detentivo e di non aver fatto ricorso al trattamento sanitario obbligatorio in considerazione del fatto che Stefano Cucchi non era in grado di autodeterminarsi. Altresì incombe la mancata identificazione, prima dell’exitus, di una condizione clinica così grave da mettere a serio rischio la vita stessa. Nessun medico nella giornata antecedente al decesso si è reso conto che la situazione aveva ormai raggiunto un punto di non ritorno. Stefano Cucchi è stato etichettato da subito come un tossicodipendente con le conseguenze che questo comporta sul piano dei pregiudizi. Il suo drammatico caso clinico non è stato gestito con le dovute attenzioni alla fragilità psico-fisica del suo corpo. Tutto ciò scatena l’indignazione più profonda e, nello stesso tempo, si fa prepotente il bisogno di verità.
Tornasse indietro rifarebbe il lavoro che ha fatto o si dedicherebbe ad altro?
Ripercorrei lo stesso cammino passo passo. Ho forse dato tanto al carcere e ai detenuti, ma avverto la necessità di ammettere che soprattutto dai detenuti ho avuto tanto, forse tutto come uomo e come Medico. Nell’intimo mi resta la soddisfazione nascosta di ciò che ho dato, il tormento segreto di questa passione: la Medicina penitenziaria, che ha il profumo terribilmente avvincente del primo amore.
Ipotizziamo che lei venga chiamato a fare il Ministro della Giustizia. Che riforme cercherebbe di realizzare per il nostro sistema carcerario? Mi può dire le prime tre cose che farebbe?
Darei priorità assoluta al lavoro penitenziario. È innegabile che il lavoro in carcere rivesta valenza terapeutica. Il lavoro in carcere significa anche muoversi, pensare attivamente, ritrovare quell’equilibrio vitale e necessario per andare avanti.
Al secondo punto il riconoscimento all’affettività e alla sessualità in carcere. I diritti elementari dell’affettività e della sessualità devono rientrare a pieno titolo negli elementi fondamentali del trattamento penitenziario. Del resto la sessualità è parte integrante dell’affettività, è uno stimolo umano, un desiderio legittimo che viene negato proprio nel momento in cui si ha più bisogno di essere rassicurati. La mancanza del sesso in carcere è mutilazione fisica, violenza, disperazione, crudeltà, brutalità; l’astinenza dal sesso è la pena nella pena. Eppure la sessualità è un atto naturale come lo è respirare, mangiare, dormire, defecare, urinare. Altrimenti sopravviene la patologia della rinuncia e della degenerazione.
Infine l’implementazione delle pene alternative al carcere e l’abolizione dell’ergastolo. Il carcere deve rappresentare l’extrema ratio. Il carcere continua ad essere purtroppo una medicina troppo amara per coloro che sono malati seriamente e di questo dovrebbero finalmente tener conto i Magistrati di Sorveglianza per il riconoscimento dei relativi benefici di legge. Vi è certo una nobile ispirazione nell’immaginare in prospettiva , qualcosa meglio del carcere, ma non possiamo rinunciare a batterci per un carcere migliore.
. . . . .
Francesco Ceraudo è stato presidente dell’Associazione Nazionale Medici Penitenziari (AMAPI) e presidente internazionale dei Servizi Medici Penitenziari (ICPMS). Per il suo lavoro ha ricevuto numerose onorificenze: Cavaliere al merito della Repubblica (1982); Gran croce al merito per la Sanità (1992); onorificenza Francisco Fayardo-Governo del Venezuela (1998).

Foto d’archivio (Wikipedia)